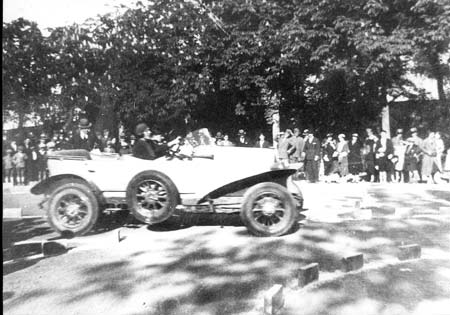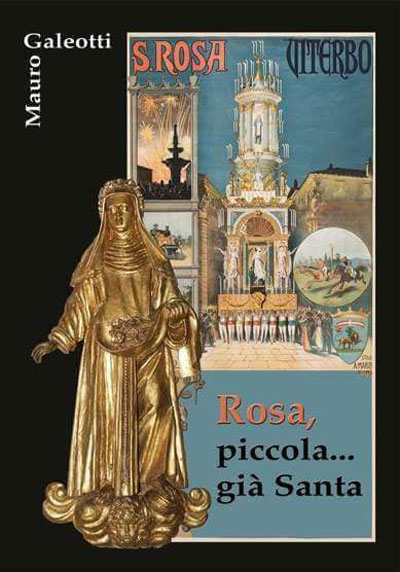Viterbo IL RACCONTO
Viterbo IL RACCONTO
Agostino G. Pasquali

IL RACCONTO: Schüttelbrot a Natale 1943 – Seconda serie. Prima puntata – Seconda puntata
L’accusa
Venne la fine di agosto e portò una grossa novità.
Lo Standartenoberjunker Waldmann ci notificò una decisione del Führer, il quale, venendo benevolmente incontro a una richiesta del Duce, concedeva il cambio di qualifica agli I.M.I. che lavoravano: non più detenuti militari ma lavoratori civili.
Formalizzata la variazione, e per conseguenza di essa, il lager di Babelsberg si trasformò in una specie di limbo, non più un luogo di pena, un inferno, ma non divenne certo un paradiso, piuttosto un penoso purgatorio popolato da cittadini stranieri civili, ospitati senza un chiaro motivo se non quello di lavorare come se fossero degli immigrati. Altra conseguenza: se ne andarono via i militari tedeschi, trasferiti al fronte occidentale dove erano indispensabili per rimpiazzare almeno in parte le perdite sempre più gravi inflitte dagli alleati.
Ci fu un certo miglioramento nelle condizioni di vita. Come lavoratori civili potevamo uscire dal lager con una certa libertà, ma solo durante il giorno e nelle ore libere dal lavoro e, poiché ora ricevevamo un salario in marchi dalla direzione della fabbrica, potevamo comprarci qualcosa da mangiare. Poteva sembrare un notevole vantaggio, ma in realtà era un’illusione perché c’era poco da comprare negli spacci legali e quel che si trovava al mercato nero costava troppo.
Giuridicamente eravamo divenuti semiliberi, ma sostanzialmente restavamo schiavi, sia pure con orario di libera uscita e comunque, quando stavamo all’interno del lager, eravamo sorvegliati. Però le guardie non erano più i soldati della Wermacht né gli uomini delle SS, ma sorveglianti civili armati di MP40 (Maschinenpistolen, pistole mitragliatrici). Che si trattasse di civili non aveva migliorato il rapporto tra noi e loro, che anzi era anche peggiorato perché i civili erano assai maldisposti verso di noi, ci consideravano traditori e quindi causa dell’insuccesso bellico. Però non vedere più i militari tedeschi in divisa nonché stare in semilibertà appariva a molti un vantaggio e dava ad alcuni l’illusione di potersi comportare come faceva comodo, diciamo pure in modo indisciplinato. Questa illusione si dimostrò pericolosa.
Scoppiarono subito incomprensioni e diverbi con i guardiani e solo il fatto che questi erano armati di MP40 evitò che si arrivasse alla rissa. Quelli avevano l’atteggiamento di chi è pronto a uccidere, anzi di chi desidera uccidere e aspetta solo il pretesto per sparare. Quindi, più che il rispetto che comunque le divise della Wermacht avevano ottenuto, era la paura delle armi a mantenere un minimo di ordine. Ma c’era nei graduati come me, responsabili di un gruppo o di una baracca, il timore che l’indisciplina provocasse prima o poi qualche brutto incidente.
I pessimisti dicono che nella vita non si può, non si deve, mai stare tranquilli perché i guai arrivano proprio quando non ce li aspettiamo. E allora, non fosse che per scaramanzia, era opportuno, come diceva Caputo, “fa’ i ccuorna” e stare pronti al peggio. Però in quel tempo, il mio pessimismo e gli scongiuri di Caputo non bastarono: il guaio ci fu e passai uno dei peggiori momenti della mia vita.
La mattina della terza domenica dopo la partenza dei militari tedeschi, un collega, il maresciallo Giullaro che era capo della baracca n. 1, prese l’iniziativa di riunire alcuni sottufficiali per concordare un’azione comune affinché i carabinieri non dimenticassero di essere ancora tali e quindi tenessero un comportamento sobrio e disciplinato.
Ci riunimmo nei locali dell’ex comando militare, nella stanza che era stata del Major Speer che al momento era vuota e inutilizzata, come del resto tutta la baracca che era stata il comando del campo. Eravamo in nove. Discutemmo per circa una mezz’ora e stabilimmo che ogni capo baracca doveva riunire i suoi uomini e spiegare che la qualifica di civili valeva solo nei confronti dei tedeschi, ma tra di noi, e quindi nei confronti dell’Italia, eravamo ancora e sempre militari tenuti al rispetto del regolamento, della disciplina e del giuramento; inoltre noi eravamo non soltanto militari, ma carabinieri, il che ci imponeva un comportamento impeccabile da ogni punto di vista. La nostra ‘Fiamma d’argento’ non si doveva mai spegnere proprio come è scritto nel nostro motto: ‘Nei secoli fedele’.
Finita la riunione, stavamo per uscire e ritornare nelle nostre baracche quando, all’improvviso, fecero irruzione sei guardiani con le MP40 spianate e pronte allo sparo. Ci intimarono di alzare le mani e brutalmente, a calci e spintoni, ci condussero fuori, al centro del cortile; qui ci ordinarono di metterci seduti a terra. Ammucchiati lì, muti e terrorizzati, chiedemmo una spiegazione, ma le guardie si rifiutarono di darcela, ci dissero solo che dovevamo aspettare l’arrivo del comandante del distretto militare di Potsdam.
Eravamo ansiosi, molto preoccupati dall’aspettativa di un brutto evento e torturati nel fisico dal freddo e dall’umidità di un autunno tedesco anticipato: era settembre, ma settembre nella Germania del nord è già praticamente inverno. Restammo così fino al primo pomeriggio quando arrivò un reparto di soldati con due camion e un’autoblindo. Li precedeva una autovettura, una Kübelwagen scoperta con a bordo un colonnello piuttosto anziano, alto magro e contegnoso, che esibiva tante decorazioni ma un braccio solo. Aveva l’aria del reduce di molte battaglie, evidentemente esonerato dai combattimenti per l’età e le menomazioni fisiche, e quindi assegnato a compiti burocratici. Ci informò, per mezzo di un interprete, che era stato incaricato di costituire una sezione speciale del tribunale militare per processarci in direttissima per i reati di sedizione e sabotaggio. Venimmo riportati nella baracca dell’ex comando, nella stanza dove eravamo stati arrestati, e dove nel frattempo era stato sistemato un grosso tavolo dietro il quale presero posto quattro ufficiali con in mezzo, a presiedere, il colonnello.
A rischio di fucilazione
Alla prima vaga preoccupazione per l’arresto era seguito un preciso terrore causato dalla dichiarazione del colonnello. Infatti sapevamo bene che il codice militare di guerra prevedeva la fucilazione per i reati di sedizione e sabotaggio.
“Ma quale sedizione?” mi chiedevo, e pensavo che se lo stessero chiedendo anche i miei colleghi di sventura. E se nei confronti dell’accusa di sedizione un po’ mi confortava la coscienza tranquilla, d’altra parte il sabotaggio mi preoccupava per quei maledetti difetti della produzione in fabbrica. Sapevo bene che i tribunali militari, specialmente in tempo di guerra, funzionano allo scopo di giudicare sommariamente e punire, soprattutto punire con scarso riguardo per le ragioni degli imputati. In quei tribunali l’accusa viene poco discussa e la difesa è più che altro una formalità.
Venne letta l’accusa che era stranamente scritta in italiano:
- sedizione: 9 sottufficiali si erano riuniti di nascosto, occupando abusivamente un ufficio del campo, per complottare una fuga assalendo le guardie,
- sabotaggio: era stato organizzato il sabotaggio della produzione compiendo errori nel lavoro e provocando incidenti ai macchinari. Quest’accusa non era però specifica per noi, ma generica a carico di tutti gli italiani del lager.
La prima accusa era gravissima, ma il peggio era che risultava presentata in un rapporto scritto in italiano e firmato da due italiani: il capo campo, maresciallo Zuffetta che era uno di noi e l’interprete, tale Valter Camosi, che non era un militare.
Il primo era un collaborazionista che, fin dal suo arrivo al lager, si era arruffianato i tedeschi e aveva svolto il suo compito come devoto e passivo esecutore dei loro ordini: mai una difesa degli internati, mai un intervento per migliorare le nostre condizioni. Però dopo la partenza dei militari tedeschi non aveva trovato un pari accordo con i nuovi guardiani civili che mostravano di disprezzarlo, e così aveva probabilmente ordito l’accusa, o comunque vi aveva partecipato, con la speranza di riacquisire i meriti e i vantaggi cui si era abituato ma adesso non aveva più.
Il secondo era un pessimo soggetto, il classico ‘leccaculo’ (mi si passi l’espressione volgare), viscido e pericoloso. Dopo l’8 settembre era entrato nella RSI (Repubblica Sociale Italiana, la repubblichina di Salò, per intenderci) e vi aveva ricoperto la carica di modesto funzionario dedito al doppio gioco dello spionaggio. Infiltratosi tra i partigiani ne aveva fatti arrestare parecchi per cui era ricercato dal CLN (Comitato di Liberazione Nazionale). Sentendosi in pericolo aveva preferito andar via dall’Italia. Avendo saputo che il Reich aveva richiesto al governo della R.S.I. alcuni interpreti, si era dichiarato bilingue perché aveva una modesta conoscenza scolastica del tedesco e si vantava di avere una vaga ascendenza austro-ungarica per via del nome che scriveva con la vu doppia ‘Walter’ e il cognome che sosteneva essere stato anticamente ‘Kamozi’. Era arrivato al lager da un paio di mesi, come interprete ufficiale, ed era accompagnato dalla pessima fama di cui ho detto, che era stata tempestivamente diffusa da Radio Fante.
La nostra situazione era molto pericolosa e ci stavamo preparando a essere condannati e fucilati. Può sembrare strano ma a quel punto non c’era più paura, per lo meno io non ne avevo e pure i miei compagni erano tranquilli o apparivano tali. Sentivo solo molta tristezza ma anche un vago senso di liberazione: almeno stavano per finire la fame, il freddo e le torture morali e fisiche.
Aspettavamo dunque che iniziasse una specie di processo, sicuramente rapido, il minimo di tempo necessario per stendere un verbale, un documento che la nota pignoleria burocratica dei tedeschi rendeva indispensabile.
Però il colonnello sembrava non avere fretta. Parlottò fitto fitto con il capo dei guardiani, esaminò i documenti che gli erano stati presentati e ne richiese la traduzione scritta precisando che non poteva emettere una condanna sulla base di documenti che non capiva. L’interprete, il Camosi, si mise al lavoro controvoglia, e si vedeva bene dallo sguardo tra l’incerto e il disperato che la sua conoscenza del tedesco era scarsa: andava a rilento e consultava spesso un suo dizionarietto. Comunque arrivò alla fine e, richiesto, cominciò la lettura del testo. Il colonnello lo fermava di tanto in tanto e gli chiedeva chiarimenti. Io ascoltavo e capivo con quanta astuta falsità i due denuncianti avevano costruito l’accusa. Capii che se ci fossimo trovati di fronte a un giudice ordinario avremmo avuto poca possibilità di difenderci. Di fronte a un tribunale militare: nessuna.
Oltre ad aver inventato una accusa falsa, ma purtroppo credibile perché le circostanze e i pregiudizi erano contro noi, il Camosi aggravava la situazione affermando che noi eravamo doppiamente colpevoli perché, oltre ad aver commesso i reati, ci eravamo approfittati della benevolenza del Führer, che ci aveva concesso la semilibertà annullando la qualifica di IMI e sostituendola con quella di freiarbeiter.
La doppiezza, la malvagità del Camosi emergevano chiaramente: tradiva i connazionali e, per ingraziarsi i tedeschi, faceva leva su una benevolenza del Führer che non esisteva affatto, ma che i tedeschi ovviamente credevano autentica. Si aggravava così la nostra posizione processuale e la condanna a morte era ormai inevitabile.
(La quarta puntata, fra una settimana)