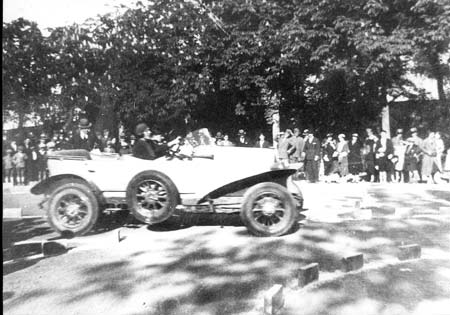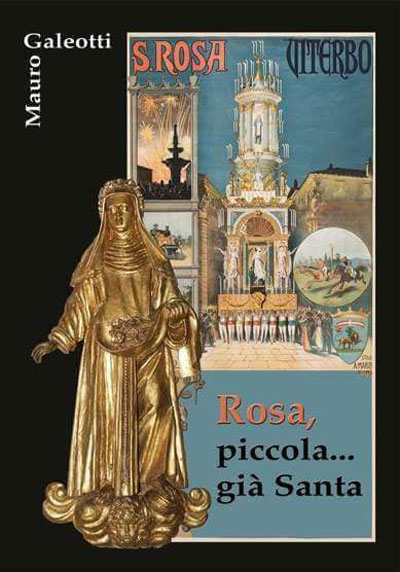Viterbo IL RACCONTO
Viterbo IL RACCONTO
Agostino G. Pasquali
IL RACCONTO: Schüttelbrot a Natale 1943 – Seconda serie. Prima puntata – Seconda puntata - Terza puntata

Processo a Potsdam
Un altro presidente del tribunale di guerra avrebbe chiuso subito il processo ed emesso la sentenza di condanna, ma quel colonnello aveva un modo di fare insolito, un atteggiamento particolarmente scrupoloso, come se avesse dei dubbi.
Quando sentì ipotizzare l’aggravante del tradimento della fiducia da parte di noi liberi lavoratori spalancò gli occhi ed ebbe un soprassalto, quindi fermò il Camosi nella lettura per chiedere:
“Freiarbeiter? Sind diese Italiener Freiarbeiter? Wirklich?” (Veramente questi italiani sono liberi lavoratori?)
Alla risposta affermativa si alzò e dichiarò solennemente (cito a memoria):
“Weil sie nicht mehr Soldaten sind, und sie kein Delikt gegen die Streitkräfte gemacht haben, so dieses Kriegesgericht nicht zuständig ist!” (Questo tribunale di guerra non è competente poiché costoro non sono più militari, né hanno commesso alcun delitto contro le forze armate!)
Quindi si mise a discutere con il capo dei guardiani del lager. Discuteva col tono di una persona infastidita, che fosse stata disturbata nell’esercizio di attività importanti. Da qualche parola afferrata al volo capii che gli stava muovendo duri rimproveri. Infatti durante il colloquio, o meglio durante il monologo del colonnello, il suo interlocutore annuiva abbassando ripetutamente la testa come una marionetta mentre sul viso appariva chiaramente il disappunto. Da qualche parola, afferrata di tanto in tanto, mi parve pure di capire che il colonnello invitasse l’altro alla prudenza in considerazione del cattivo andamento della guerra che non consentiva più al Reich atteggiamenti di prepotenza e disprezzo delle leggi internazionali.
D’altra parte la scorciatoia giuridica che il colonnello aveva preso, la dichiarazione di incompetenza, lasciava supporre una sua certa repulsione per i processi sommari da inquisizione medioevale, un rifiuto di quella ostentata cattiveria nazista che noi italiani attribuivamo ai tedeschi. E ne avevamo buoni motivi.
Il colonnello avrebbe potuto benissimo processarci, condannarci a morte ed eseguire subito la condanna, non dico al rogo, questo è ovvio, ma alla fucilazione. Nessuno avrebbe protestato. Peraltro non tutti i tedeschi erano cocciutamente nazisti, bestialmente cattivi. In qualcuno ma forse in molti, più di quanti si possa pensare, sopravviveva un barlume di apertura mentale verso la saggezza e la tolleranza; oppure quel barlume, temporaneamente oscurato dalla propaganda nazista, si stava riaccendendo in conseguenza degli insuccessi militari che facevano prendere consapevolezza dei tragici errori della politica insensata di Hitler.
Nel piccolo circolo dei tedeschi che mi erano divenuti simpatici (Major Speer, Herr Bremenz, Frau Walpurga) aggiunsi un posticino per il colonnello.
Però ora, mentre scrivo e ci ripenso, mi viene il dubbio di averlo sopravvalutato quel colonnello, perché in realtà non ci aveva affatto assolti, ma si era ‘lavato le mani’, aveva agito come uno dei tanti Ponzio Pilato che, dal processo a Gesù in poi, evitano di fare il loro dovere scaricando su altri le questioni scottanti.
Comunque per noi fu meglio un Ponzio Pilato che uno dei famigerati tribunali tipo inquisizione, perché tali sono sempre stati, per i preconcetti e la brutalità, i tribunali militari, e non solo quelli tedeschi.
Così scampammo il rischio di un processo sommario con condanna a morte certa e immediata, ma restammo comunque in arresto perché l’accusa rimaneva valida, però doveva essere giudicata da un tribunale penale ordinario.
In conclusione fummo caricati su uno dei due camion, portati a Potsdam e rinchiusi nel carcere mandamentale.
Del periodo passato in carcere a Potsdam ricordo la brutta noiosa angosciante attesa del giudizio, e mi torna per contrasto vivido, come se fosse ieri, il ricordo della pazienza, dello spirito di sopportazione e dell’efficienza della popolazione civile tedesca. Era costantemente tormentata dal passaggio degli aerei alleati che quasi tutte le notti andavano a bombardare Berlino e le altre città del nord, o ne tornavano dopo aver bombardato. Spesso lasciavano cadere le bombe anche su Potsdam, specialmente durante i ritorni perché gli aerei che per qualche motivo non avevano sganciato tutte le bombe ne approfittavano per liberarsene bombardando anche la città e i sobborghi.
La popolazione, cioè le donne i bambini e gli anziani (i giovani e gli uomini adulti non c’erano perché stavano al fronte), veniva avvisata dalle sirene e correva ai rifugi; così quasi tutti si salvavano dalle bombe ma, finito l’allarme, trovavano la città danneggiata. E tuttavia, la mattina seguente, Potsdam riprendeva un’aria di normale efficienza e tutte le attività produttive e i servizi pubblici e privati continuavano a funzionare. Quando c’era stato un forte bombardamento locale con gravi danni agli edifici, avvenimento tutt’altro che raro, avveniva che, già al mattino presto, numerose e ordinate squadre di operai si dedicavano a sgomberare le strade dai detriti e curavano la ricerca di sopravvissuti alle bombe che potevano essere ancora imprigionati sotto le macerie.
Come facevo a sapere questo? Lo seppi perché, accanto a quegli operai, per lo più uomini anziani con il bracciale della protezione civile, c’erano anche i carcerati che si offrivamo volontari per spirito umanitario e per stare almeno per un po’ fuori dalle celle. Perché appunto partecipammo anche noi, che eravamo carcerati, allo sgombero delle macerie. Lavoravamo accanto gli uni agli altri, detenuti e civili, né nemici né alleati, ma preoccupati solo di rimediare per quanto possibile agli orrori della guerra.
Grazie a questa efficiente opera di normalizzazione, il tribunale penale ordinario istruì e concluse in poco più di una settimana il nostro processo. Già al terzo giorno eravamo stati interrogati da due magistrati con l’assistenza di un distinto signore italiano, un certo dottor Marsello, che era stato distaccato dal nostro consolato con la funzione ufficiale di interprete, ma si comportava sostanzialmente come nostro difensore. C’era anche per noi un avvocato tedesco nominato d’ufficio, ma interveniva raramente perché conosceva pochissimo la nostra lingua e nient’affatto gli avvenimenti che erano l’oggetto del processo.
Avemmo così la possibilità di chiarire i fatti dal nostro punto di vista e ci sembrò subito che i due magistrati fossero ben disposti nei nostri confronti. Restava però la denuncia scritta e l’incognita dell’interrogatorio dei sottoscrittori e dei guardiani. A questi interrogatori, avvenuti il quinto giorno, non fummo presenti ma ce ne riferì l’essenziale il dottor Marsello. Ecco in breve come avvennero.
Il capo campo maresciallo Zuffetta, richiesto di specificare se i nove sottufficiali arrestati nell’ufficio vi si trovassero illegalmente avendo commesso un abuso, un’occupazione illecita, ammise che quei locali, abbandonati dai militari, erano disponibili per tutti; richiesto di chiarire gli elementi che l’avevano portato a pensare alla sedizione, rispose che così gli era sembrato, che forse aveva agito con troppo zelo, ma si era limitato ad allarmare i guardiani della insolita riunione, l’aveva fatto per prudenza e solo nell’interesse del Reich; che erano stati i guardiani ad agire affrettatamente e se ne dispiaceva; ammise che non sapeva nulla del sabotaggio, che lui in fabbrica non ci era mai entrato, ma che si parlava, anche da parte degli stessi lavoratori, di guasti delle macchine e di produzione difettosa; dichiarò infine che la denuncia scritta gli era stata imposta dai guardiani ad arresto avvenuto e in funzione dell’arrivo dell’autorità militare.
Il capo dei guardiani dichiarò di aver raccolto la segnalazione del capo campo Zuffetta e di aver arrestato a scopo cautelare i nove, richiedendo subito l’intervento della autorità militare; personalmente non aveva alcuna prova di sedizione e non sapeva nulla di eventuali sabotaggi.
Valter Camosi negò semplicemente ogni conoscenza dei fatti e dichiarò che aveva sottoscritto la denuncia perché la firma gli era stata chiesta dal maresciallo Zuffetta il quale, essendo capo campo, era responsabile della disciplina e del comportamento degli internati. Nella sua intenzione quella firma era stata semplicemente l’apposizione del visto di convalida formale del documento, non una condivisione del suo contenuto.
Insomma ognuno aveva scaricato la colpa sugli altri, come avviene spesso nel caso di calunnie costruite sul sentito dire e sul malanimo, e nessuno era disposto a farsi carico dell’accusa.
Ora potevamo sperare bene, che il processo si potesse chiudere per insufficienza di prove, ma i giudici ritennero opportuno interrogare anche il direttore della fabbrica. Lo convocarono per l’udienza conclusiva che era prevista il martedì successivo
Alla deposizione di Herr Mayerfeld fummo presenti anche noi accusati perché, salvo imprevisti, subito dopo sarebbe stata pronunciata la sentenza.
Herr Mayerfeld ammise che problemi di produzione c’erano, ma era normale. Precisò che esistevano tabelle con i limiti di tolleranza degli scarti e che i suoi operai non li avevano mai superati; quanto ai macchinari, sì, certamente si rompevano, ma perché erano vecchi, usurati, e la Wermacht gli richiedeva dei ritmi produttivi esasperati che lui riusciva a rispettare proprio per la disciplinata collaborazione degli addetti.
Da accusati di sabotaggio divenimmo nelle sue parole diligenti operai.
Mi chiesi allora, e me lo chiedo ancora adesso, se Mayerfeld sia stato sincero oppure se, per qualche suo scrupolo, abbia voluto aiutarci. Probabilmente sono valide entrambe le motivazioni: aveva detto il vero, ma anche aveva avuto qualche scrupolo perché, come ho già riferito, molti tedeschi cominciavano a dubitare della politica nazista e del buon esito della guerra, e quindi cercavano di prendere le distanze dal sistema politico e dai militari.
Comunque, a questo punto, l’assoluzione era molto probabile e noi ci contavamo.
Quasi liberi a Potsdam
Infatti fummo assolti per “non aver commesso il fatto” e con questo il tribunale chiuse il procedimento in senso stretto, però non dette alcuna disposizione sulla nostra posizione giuridica, su cosa dovevamo fare e dove andare, né dispose alcunché circa l’eventuale ritorno al lager di Babelsberg.
Questo è sovente, ancora oggi, il difetto delle sentenze penali, perché i giudici si occupano solo del fatto contingente e trascurano le conseguenze future e gli effetti collaterali di quello che stabiliscono in sentenza. Dunque è come se dicessero: “Sei libero, esci e t’arrangi”, oppure: “Sei condannato, vai in carcere e poi quando esci sono c… tuoi.”
A noi era andata bene e, appunto in conseguenza della sentenza, eravamo più o meno liberi come freiarbeiter, quindi il primo pensiero fu quello di scappare sfruttando la insperata libertà che quel giudizio ci aveva concesso. Ma non avevamo documenti e sarebbero stati, come ho detto, c… nostri. Non potevamo certo andarcene dove volevamo perché al primo controllo saremmo stati arrestati come stranieri vagabondi o peggio come evasi da un campo di concentramento e magari considerati spie. Avremmo potuto giustificarci raccontando i fatti e chiarendo la nostra situazione giuridica di ex IMI, lavoratori civili del lager di Babelsberg, ma in tal caso, se ci andava bene, là saremmo stati riportati. Allora tanto valeva tornarci subito spontaneamente. E questo fu il suggerimento del dottor Marsello, il funzionario del consolato, che si offrì pure di procurarci un mezzo di trasporto. Però tornare al lager era proprio ciò che io non volevo.
(La quinta puntata, fra una settimana)